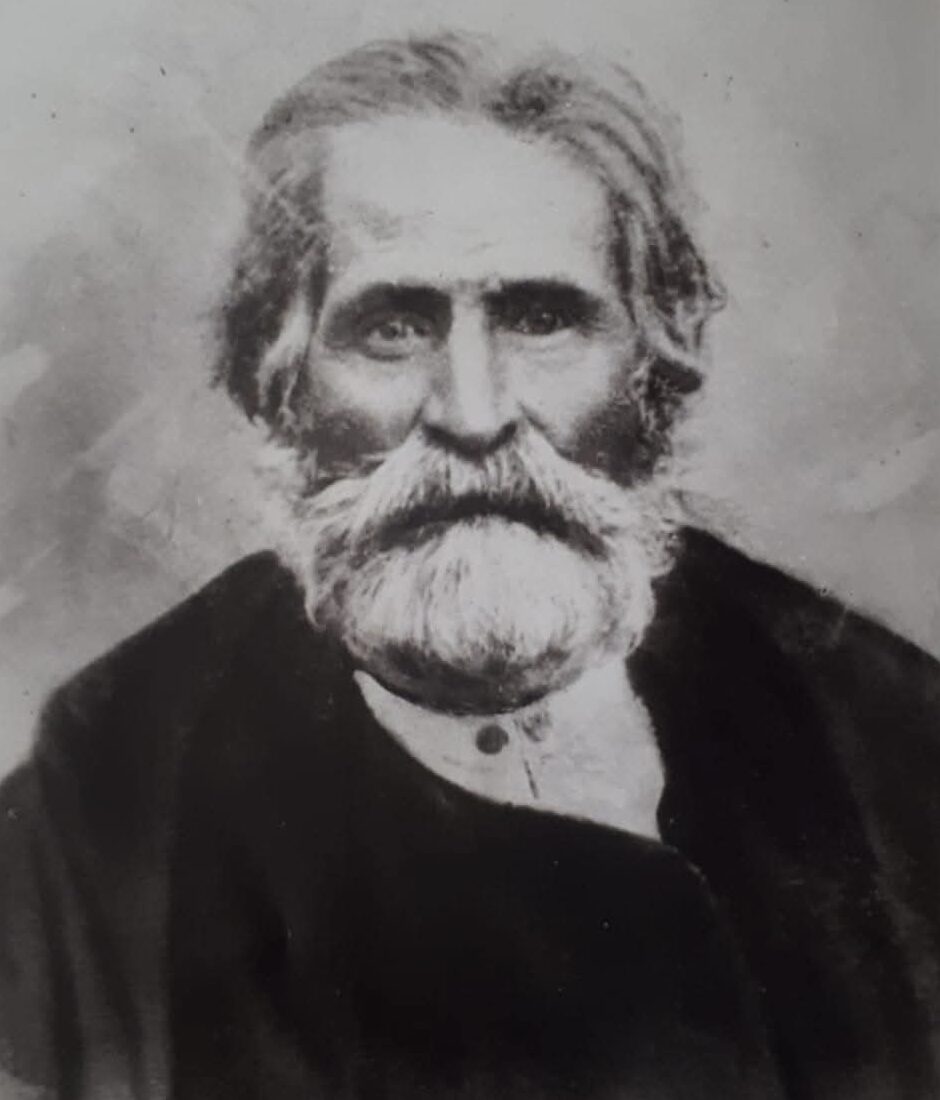Certe parole sono come degli scrigni, e aprirle, dissezionarle significa talvolta capire il modo di pensare di un popolo.
In sardo la parola imparàre si usa per indicare sia l’atto di imparare, apprendere che quello di insegnare. Quindi, se dire “imparo sa limba sarda” significa appunto “imparo la lingua sarda”, “T’imparo sa limba sarda” si traduce con “Ti insegno la lingua sarda”.
Come spesso accade, la lingua sarda aveva già saputo esprimere con un’immagine concisa un concetto fondamentale, concetto poi esposto persino da Nietzsche: gli opposti sono illusioni, e tra dare e ricevere non c’è poi così tanta differenza. Così come l’altruismo e l’egoismo sono due lati della stessa medaglia, e spesso chi dà troppo è un egoista mascherato.
In un mondo in cui la scuola istituzionalizzata, così come la conosciamo oggi, esisteva per poche persone, c’erano tanti maestri sparsi per i paesi sardi, che non avevano dubbi sul fatto che imparare e insegnare fossero la stessa cosa, ed erano ben consapevoli del fatto che non avrebbero mai dovuto smettere di insegnare (e quindi di imparare) nel corso della loro vita. Tanto che, anche dopo aver appreso a tutti gli effetti una certa professione, continuavano a chiamarsi Maestri: in sardo, infatti, le professioni vengono indicate con l’appellativo “Mastru”. Un muratore si chiama “Mastr’e’ Muru” (maestro di muro), un falegname si chiama “Mastr’e’ Linna” (maestro di legna) e così via.
In quel mondo comunitario, l’esperienza non era una porzione di cibo individuale da mangiare da soli, ma già nel linguaggio era implicita la filosofia del sapere condiviso. Tutti avevano l’implicito dovere di tramandare la propria esperienza a qualcuno, e questo rendeva ovviamente le relazioni più solide. Oltretutto, l’insegnamento era individuale, a differenza delle classi di 20 o più allievi che si formano nelle scuole, numero che rende l’efficacia dell’apprendimento molto dubbia visto che, per un insegnante, capire l’individualità di ognuno e seguirlo di conseguenza risulta così molto complicato.
Già con l’avvento della televisione iniziò lentamente il declino di questo sistema: le persone avevano un punto di riferimento comune e nazionalizzato da cui prendere le informazioni e, colui che prima era considerato saggio, divenne vecchio e venne buttato via in poco tempo. L’apice di questa omologazione si raggiunse poi con l’avvento di Google, per poi oggi sfociare nell’intelligenza artificiale, che ha preso il posto dei vecchi maestri. La differenza è che non è un essere umano a imparare mentre ci insegna (ebbene sì, ogni volta che chiediamo qualcosa a ChatGPT, immagazzina informazioni per addestrarsi meglio), ma un robot digitale che l’uomo, ignaro delle conseguenze, userà per non sforzarsi più a pensare.
E’ chiaro che l’intelligenza artificiale porterà enormi vantaggi, come ad esempio in ambito medico: ho letto proprio ieri un articolo che spiegava i progressi a livello preventivo, e mi è sembrato veramente di leggere una storia di fantascienza.
Ma il rischio che corriamo è che lo stesso progresso, pur aumentando efficienza e conoscenza, possa spegnere quel legame umano che, per secoli, ha arricchito interiormente le persone. L’insegnamento e l’apprendimento sono legati a relazioni genuine e, se queste relazioni vengono indebolite o disgregate, rischiamo di perdere proprio ciò che dà valore alla vita: la nostra capacità di essere veramente felici attraverso il contatto umano.
A livello umano infatti, la separazione tra il maestro e l’allievo è purtroppo quasi al completo, motivo per il quale le relazioni basate su questo scambio reciproco sono destinate a morire.
Forse, se tornassimo a concepire la conoscenza come un atto comunitario, potremmo salvare ancora qualche “Mastru” e, in questo modo, salvare anche la felicità umana, invece di darla in pasto all’intelligenza artificiale.
La vera ricchezza sono le persone.