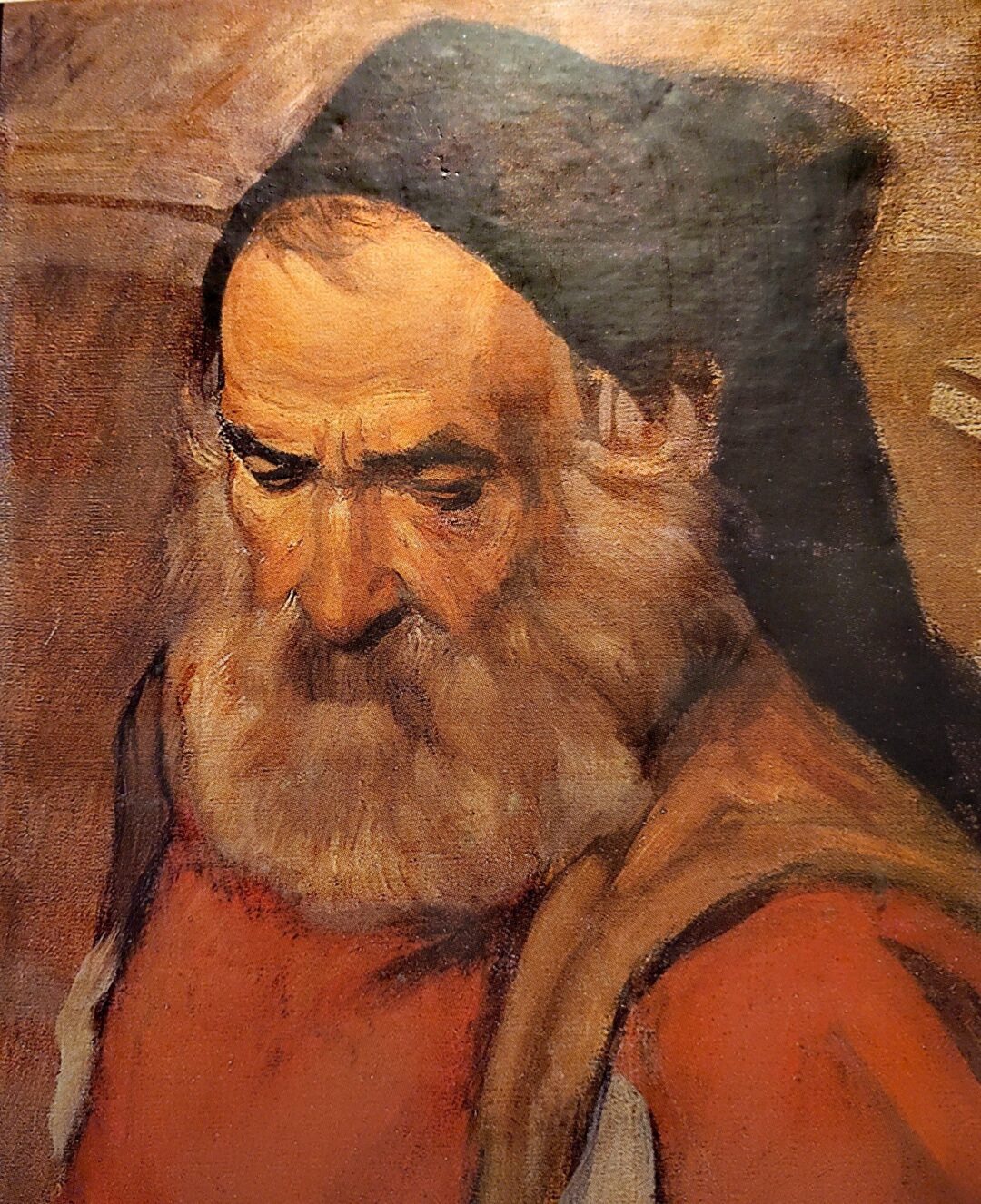“La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri” Gustav Mahler.
C’è odore di bruciato nell’aria. Ma oltre alla fiamma del lentischio che brucia, si sente un odore di bruciato più pungente: sono gli occhi dei giovani che bruciano di non-si-sa-cosa.
Questa non è una festa come le altre, una festa nel vero senso del termine come lo intendiamo oggi. E non è neanche un mero susseguirsi di azioni come spesso si sente descrivere in modi fiabeschi ma che, sinteticamente, sarebbe questo: la mattina gli uomini tagliano le frasche mentre le donne rimangono in casa per accogliere i bambini che simulano, di casa in casa, una specie di “dolcetto o scherzetto” sardo. La sera ci si incontra tutti in piazza dove al centro è conficcato un tronco di Eucalipto molto alto e, accese le frasche, gli uomini si sfidano per raggiungerne la vetta. Fine.
No, non è solo questo.
Voglio azzardare a scrivere una riflessione che si sporge al di là di tutto ciò, e che prova a scavare dentro l’anima delle persone, precisamente dei giovani, consapevole di quanto questo possa essere un pò azzardato e ambizioso.
Ma io, giovane sarda, emigrata e ancora mezzo confusa, provo delle sensazioni talmente forti quel giorno, che non posso ignorare.
Iniziamo dall’inizio: questa “festa” è un rito antichissimo che ha resistito fino ad oggi, pare che sia ancora lì quasi per continuare a ricordarci vagamente chi siamo e da dove veniamo. Conosciuta come “la festa di Sant’Antonio Abate”, in realtà è un arcaico rito pagano che, come tanti altri riti dell’isola, la chiesa ha tentato inizialmente di estirpare ma, non potendo combattere la sottile e tipica linea resistenziale della popolazione sarda, ci ha ficcato dentro la storia di Sant’Antonio che è sceso all’inferno a prendere il fuoco, riuscendo comunque a risalire in superficie. Quindi, si potrebbe definire questa giornata così: un culto pagano innestato al cattolicesimo. Solo che è un innesto che non ha attecchito bene, e qualunque osservatore poco attento se ne accorgerebbe.
Per esempio, l’intero rito si basa sul vino, e non intendo di certo il vino come sangue di Cristo: ognuno che vi prenda parte attivamente è almeno un pò alterato dal vino, quindi vino inteso come chiave di accesso a un lato dionisiaco dell’anima, repressa e solitaria durante tutto l’anno. Vino inteso come un Dio che trascina i suoi seguaci in un’estasi che dissolve le regole.
Il contrasto a parer mio più incredibile, si nota nei minuti precedenti alla scalata del tronco: mentre il prete gira tre volte intorno alle frasche in fiamme, simulando così la discesa e risalita del nostro Sant’Antonio dagli inferi, una massa di giovani completamente ubriachi e, direi anche un po’ eretici, si avvicina al fuoco impaziente. Eppure io mi ricordavo che l’ubriachezza volontaria rientra tra i peccati contro la temperanza, ma qualsiasi prete passato a Lodè pare ci abbia sempre ridacchiato sù (non si sà se per imbarazzo o per smarrimento).
Poi c’è l’enorme tronco di Eucalipto che non si sa bene cosa dovrebbe rappresentare nella favola di Sant’Antonio (che poteva scendere le scale dell’inferno anche senza quel coso enorme conficcato lì in mezzo). Invece, basandoci sui riti agrari della fertilità e del ciclo dell’eterno ritorno, il tronco potrebbe rappresentare il fallo (anche questo non ci va proprio a nozze con i principi della chiesa). Così come il fuoco: simbolo di rinnovamento, sacrificio e purificazione e legame tra l’uomo e il divino, legame alla base dell’estasi dionisiaca (Dioniso era infatti il dio (di-vino) del vino). Il fuoco che si spegne e ritorna, che brucia l’identità per farne nascere una nuova, che bruciando ci riporta all’idea eraclitea del “Panta Rhei” (tutto scorre), cioè all’ idea che nulla è statico, che tutto cambia.
Fatta questa piccolissima premessa per contestualizzare vagamente ciò che era questo culto e facendo un salto nel presente, ci si potrebbe chiedere cosa rappresenta questa giornata oggi, soprattutto per i giovanissimi sardi, vittime sacrificali di un’epoca di transizione.
La crisi identitaria che attraversa l’isola è forse il risultato di una serie di confusioni e incomprensioni che, sommate nel tempo, hanno creato un vuoto un po’ troppo pesante da sopportare. Questo fardello è sulle nostre spalle.
Intuire da dove si viene, senza capire veramente chi si è, può essere molto doloroso.
Mi direte voi: può essere considerato normale in gioventù, certo.
Ma io credo che ciò di cui sto parlando non sia solo una crisi adolescenziale, ma una crisi generazionale che, a quanto pare, perdura nel tempo. Come una ferita mal curata che s’imputridisce.
Tutto il mondo ha il mito del passato ma, in un posto come Lodè, pare che questo mito sia un freno al presente, pare che ci si voglia attaccare nevroticamente alle sue ceneri perché altrimenti non si sa più a cosa aggrapparsi.
Quindi, il rito si è inceppato: il fuoco che brucia la vecchia identità per farne nascere una nuova, pare sia spento da molto tempo e fatichi a riaccendersi.
Per dirla con le parole di Gramsci : “Il vecchio mondo sta morendo, il nuovo mondo fatica a nascere, e in questo chiaroscuro nascono i mostri.”
Io non penso che noi giovani siamo effettivamente dei mostri, ma penso che, in potenza, potremmo diventarlo.
Ora vi starete chiedendo che-cavolo-c’entra-il-culto-pagano-con-questa-roba-qui?
Come ho detto prima, questa giornata è, sì, una festa, ma non ha nulla a che vedere con il modo in cui generalmente s’intende una festa.
Prendiamo per esempio una festa qualsiasi, in una qualsiasi discoteca berlinese o di qualsiasi altra città: persone perse, quasi costrette a divertirsi che, imbottite di alcool e droghe, tentano di evadere da loro stessi. Gli occhi non bruciano, le palpebre semi-aperte. Un classico film visto e rivisto, il cui trailer si vede nelle facce dei superstiti la domenica mattina.
Ciò che succede il 16 Gennaio a Lodè, mi permetto di dire, è quasi il contrario: invece che un tentativo di evasione, pare che, per noi giovani sardi, questo sia l’unico modo di tornare da noi stessi. Tornare a toccare con mano una parte fondamentale di noi, che intuiamo ma non conosciamo, che non abbiamo mai vissuto a pieno, ma che ci assilla costantemente. E’ uno spiraglio di cultura talmente intrinseco nel nostro sangue che, in mezzo a un mondo divorato dalle intelligenze artificiali, riesce ad emergere, imponente, facendo così rifiorire ogni anno, un tipo di intelligenza inconscia: quella storica e collettiva. Una specie di memoria condivisa che ci spinge a provare rabbia quando abbiamo un mondo dentro che non riusciamo a spiegare a parole.
Infatti, per riuscire a spiegare qualcosa, bisogna conoscerla bene. Ma, come spesso accade in Sardegna, chi osserva le sue contraddizioni dall’esterno, ne rimane affascinato e pieno di dubbi. Chi l’ha vissuta in prima persona invece, non si fa più domande, rimanendo quindi a osservare le ombre di un passato contaminato, confuso e adorato da tutti, ma la cui sopravvivenza potrebbe rappresentare una piccolissima fiamma per vederci più chiaro una volta per tutte, risanando quelle ferite aperte che non sono mai guarite.