Con un ben calcolato e ridondante Freut-mich-dich-wieder-zu-sehen!, Sono-contento-di-rivederti!, due amici tedeschi si rincontrano dopo molto tempo. Hanno entrambi la stessa espressione e si comportano proprio come dovrebbero comportarsi. É estate, gli uccellini cinguettano ed entrambi hanno un’espressione educata, ma artificiale quanto quella di una donna che posa per la pubblicità di un dentifricio. Non una parola o un gesto fuori posto.
Io, spettatore esterno e invisibile, seduta in un angolo a fumare una sigaretta, percepisco un contrasto molto fastidioso dentro di me: è come se fossi divisa in due, e una parte di me trova che sia tutto perfetto, ma una parte di me percepisce che sia tutto troppo perfetto. Manca qualcosa, ma non so cosa.
Questo è un sentimento che ho provato per moltissimo tempo dopo essermi trasferita a Berlino, e solo molti anni dopo sono riuscita a capire qual’era il “problema”, riuscendo a esprimerlo a parole e, di conseguenza, a liberarmi di un peso.
Una volta, parlando con una ragazza tedesca, mi raccontò che i suoi genitori, in un modo o nell’altro, la spingevano ad andarsene di casa. Era ancora giovanissima, neanche ventenne, quando dovette farlo, e pochissimo tempo dopo il suo trasloco, la sua stanza era già stata trasformata in un salotto. Tradotto: non era più la benvenuta. Sorrisi con un pizzico di malinconia pensando a mia madre, che ancora oggi rammenda con gioia il mio letto, o a mia nonna che non vedeva l’ora di farmi ingrassare come un tacchino, sapendo che prima o poi sarei tornata casa.
Voi direte: sì, ma questo atteggiamento è un’arma a doppio taglio e ha creato una società di bamboccioni! Sono d’accordo. Ma sapere che c’è qualcuno che ti ama e che, qualsiasi cosa accada, è pronto ad aspettarti (nei limiti del ragionevole) ti dà forza e sicurezza. A meno che tu non abbia un quoziente intellettivo troppo basso. E poi, come ogni cosa, anche l’amore va saputo dosare. Ma questa è un’altra storia.
Dicevo, la società tedesca è una società che in modo prepotente, pone le regole e le funzioni sociali davanti all’empatia diretta. Motivo per il quale più o meno tutto ha sempre funzionato in modo quasi perfetto. Almeno fino a poco tempo fa (ma questa è un’altra storia ancora).
I tedeschi tendono a seguire norme di comportamento implicite che rendono la convivenza più fluida ed efficiente, ma anche terribilmente noiosa. Per esempio, se un tedesco si siede in un ristorante e prende in mano il menù, è molto raro che desideri un piatto non presente nella lista. Ho maturato l’idea che questo succede perché un tedesco guarda il menù non come un suggerimento, ma come un insieme di scelte già ottimizzate per il funzionamento di un determinato sistema, forse perché lui percepisce la sua stessa vita come un sistema. Chiedere qualcosa di diverso significherebbe disturbare l’ordine stabilito, facendo perdere tempo al cuoco, al cameriere e rallentando l’intero meccanismo.
Questa intuizione mi è balzata in testa quando, uno dei primi anni in cui vivevo qui a Berlino, mentre lavoravo in un ristorante in centro, mi capitò di servire un tavolo di ragazzi italiani, precisamente napoletani. Mentre uno di loro non riusciva a decidere quale pizza scegliere, gli altri facevano battute, implicite e non, che ci facevano ridere e che, di conseguenza, mi facevano perdere tempo nel lavoro, visto che il locale era pieno e i tavoli avrebbero dovuto liberarsi in fretta per far girare il meccanismo. Alla fine, non trovando nessuna pizza che soddisfacesse le sue esigenze, il tipo iniziò a inventarsene una lui, combinando ingredienti di diverse pizze (o forse lo fece apposta e voleva solo parlare più a lungo con me, ma questo non lo sapremo mai). Morale della favola: servendo quel tavolo persi una quindicina di minuti tra risate, desideri particolari e battutine implicite. Dopodiché, persi altri dieci minuti per spiegare come doveva essere fatta questa benedetta pizza al pizzaiolo (che, tedesco più che mai, entrava in crisi solo al pensiero di aggiungere quattro foglie di basilico al posto di tre).
Fu lì che pensai: oh-ma- se-tutti-facessero-così-che-casino-diventerebbe-questo-lavoro!, ottenendo così una probabile risposta del perchéì la Germania è noiosa ma funziona meglio dell’Italia. Non è questione di intelligenza, anzi il contrario: avendo una mente impostata in una modalità di eterno pilota automatico, i tedeschi hanno meno creatività, la quale è sintomo di intelligenza, e ogni loro comportamento si incastra perfettamente in delle caselle preimpostate, facendo girare tutto in modo più fluido.
Il pilota automatico funziona benissimo in ambito lavorativo, infatti sarò sempre grata a questa terra per avermi insegnato l’organizzazione, l’ordine e la precisione. Ma quando ci si accorge che questo modo di fare è talmente radicato nelle persone da essere trasferito anche nelle relazioni, allora scatta un problema, perché sacrificare le emozioni in nome della disciplina quando si tratta di interazioni umane, è come avere al collo un gioiello falso che brilla solo da lontano. Ad avvicinarsi troppo, soprattutto per chi è cresciuto in una terra calda e accogliente come la mia, si ha una sensazione di nodo alla gola.
Uno scenario simile è stato descritto in modo maestrale da Thomas Mann, nel suo romanzo I Buddenbrook, che narra di una famiglia tedesca ossessionata dall’immagine pubblica e dal mantenimento del proprio status sociale, ossessionata dal comportarsi esattamente come ci si doveva comportare. Questa ossessione li portò immancabilmente a reprimere emozioni e desideri che potevano ledere la loro reputazione agli occhi della società. Ma alla fine questa repressione ha leso più la loro felicità che il loro status sociale. L’infelicità del figlio minore, un’artista molto sensibile, incapace di adattarsi alle rigide regole imposte dalla sua famiglia, lo porterà ad ammalarsi e a morire.
La lezione di vita di questa storia sta proprio nel fatto che l’incapacità di esprimere pienamente le emozioni costruisce una società apparentemente solida, ma estremamente fragile e infelice. Molti tedeschi appaiono efficienti e disciplinati, ma alla fine sembrano incapaci di creare legami profondi e autentici.
Che io stia osservando un fenomeno culturale generale mi sembra ovvio e non ha bisogno di essere sottolineato: ho incontrato dei tedeschi straordinari, intelligentissimi e anche empatici (incredibile!). Ma dopo dieci anni in Germania, devo ammettere che sono davvero pochissimi e che questo è un vero peccato.
Comunque, dopo molti anni, sono finalmente riuscita a decifrare questo mio fastidio nell’osservare un comportamento apparentemente altruista ma distaccato, una gentilezza che è più una norma sociale che un vero coinvolgimento emotivo.
Quindi, il mito della Germania come terra paradisiaca era, appunto, solo un mito: ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di dirlo.

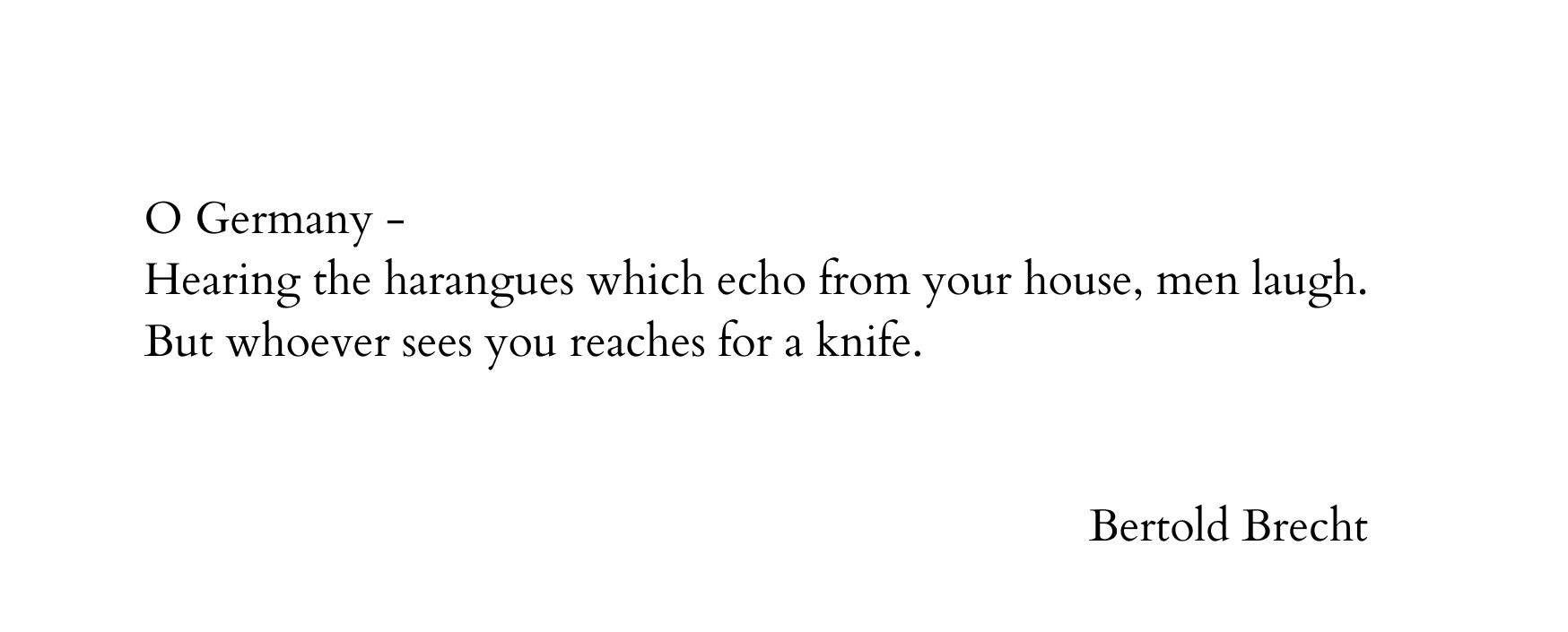


1 commento
Bravissima, ben scritto e pieno di emozioni, continua questo lavoro investigative, e molto importante !